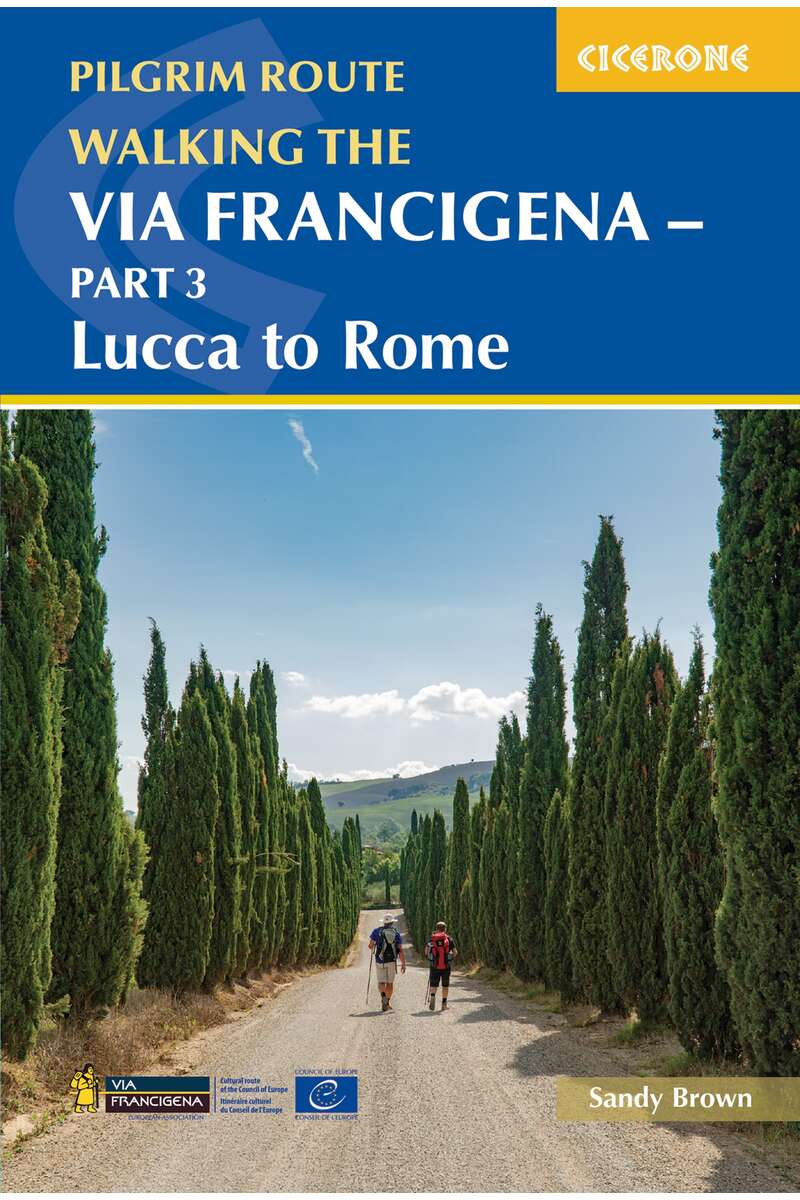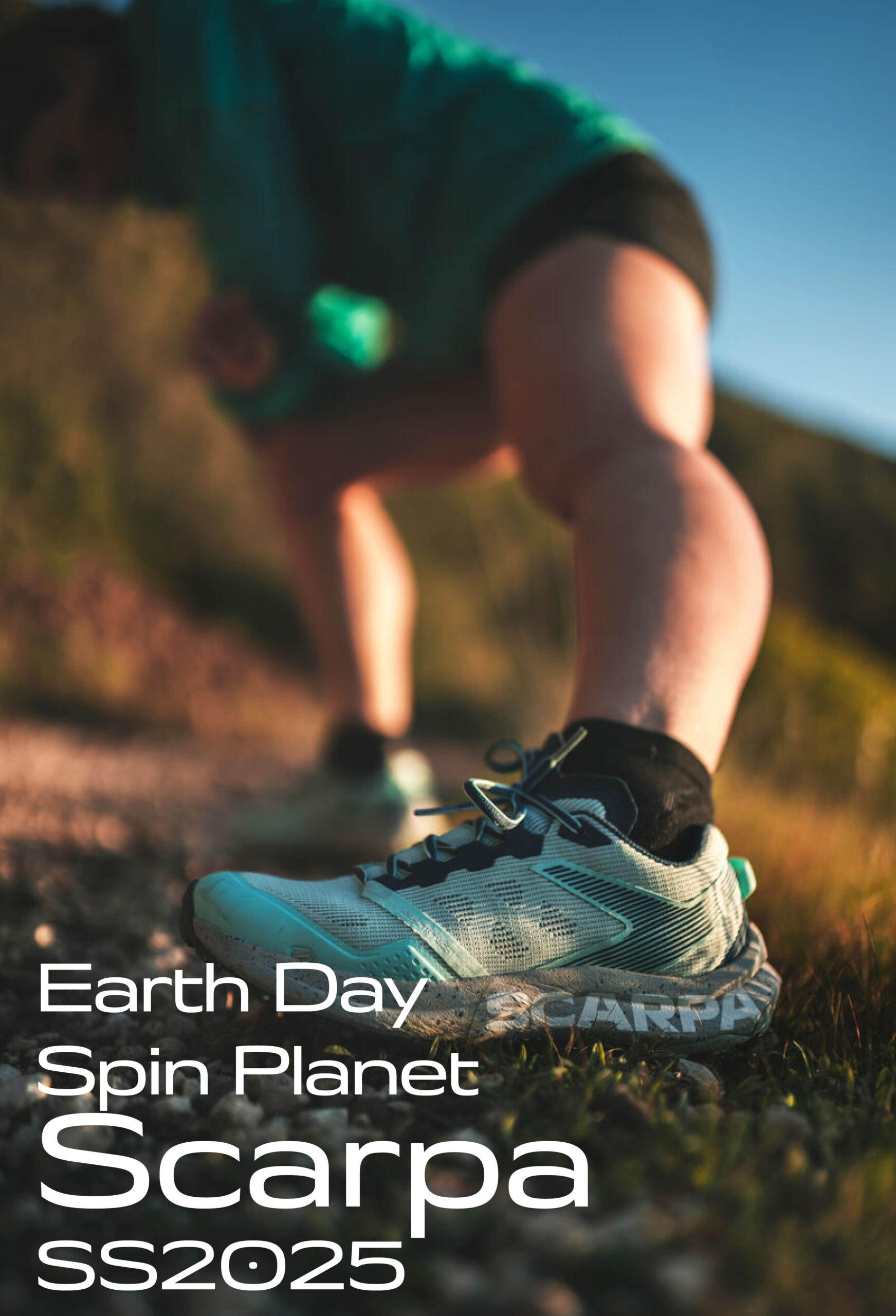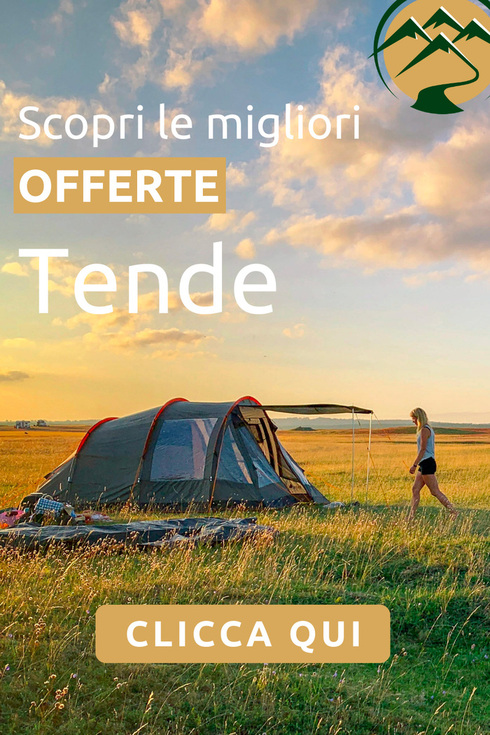A piedi in Sicilia. Diario di 153 chilometri, da Agrigento a Giammichele

Anche la Sicilia si è aperta al turismo lento e ha riscoperto antiche vie dove, un tempo, si
svolgevano pellegrinaggi e commerci. Quasi mille anni fa, i Normanni costruirono sulle tracciature
romane un intero sistema di mobilità, e chi vuole ripercorrerlo a piedi, oggi, ha quattro possibilità:
Magna Via Francigena, da Palermo ad Agrigento, Via Normanna, da Messina a Palermo, Via
Francigena Fabaria, da Agrigento a Randazzo o a Noto, e la Via Francigena Mazarense, da
Agrigento a Marsala e poi fino a Palermo.
Di alcune avevo sentito parlare. Ma la Via Fabaria mi era totalmente ignota, finché non ho aperto
l’omonima Guida scritta da Davide Comunale, Irene Marraffa e Salvatore Balsamo, non solo autori
ma promotori di questo itinerario. Tra la lettura e il momento della partenza saranno passati, al
massimo, cinque mesi.
Il Cammino è praticabile quasi tutto l’anno, a parte i mesi estivi. Ho scelto e consiglio ottobre,
giornate ancora abbastanza lunghe, clima non troppo caldo, alloggi disponibili. Per tutto
l’equipaggiamento (costume da bagno incluso) lo zaino da 30 litri è più che sufficiente. Partiamo in
due con il traghetto da Napoli, arriviamo a Palermo e prendiamo il treno per Agrigento, già muniti di
credenziali. Non occorrono lunghi tempi per organizzare il viaggio e il percorso, prenotiamo di
giorno in giorno. L’unico problema è scegliere l’itinerario, perché entrambe le alternative fanno
gola. Dopo le prime 7 tappe, infatti, si può proseguire verso l’Etna, percorrendo in tutto circa 300
chilometri, o scegliere la variante Iblea, che attraversa Ragusa e arriva fino a Noto (290 km circa).
Partire da Agrigento significa visitare la Valle dei Templi, mangiare degli arancini da primo premio,
immergersi in folle di turisti spesso prive del conforto di cartelli indicatori bilingue. È ideale per chi
ama il viaggio lento, perché è ricca di bellezza, di angoli da scoprire, di sistemazioni semplici a
prezzo accettabile, di bellezze naturali a portata di passo o di mezzo pubblico. Ma deve ancora
abituarsi ad accogliere i viaggiatori a piedi, e se qualcuno ha già sentito parlare della Magna Via
Francigena, nessuno conosce la Fabaria. La mostriamo noi, sulla Guida. Anche farsi apporre il
timbro sulle credenziali non è facile, ci riusciamo solo tramite le indicazioni telefoniche del
referente di tappa.

Indice:
Giorno 1, da Agrigento a Palma di Montechiaro
I paesaggi sono ipnotici. Uscendo dalla città abbiamo, a sinistra, i templi greci, sullo sfondo il mare.
A poco a poco ci si trova tra alture leggere e macchia mediterranea. Non ci sono fontane, né
chioschi. Ma soprattutto niente ombra. Non un albero. Il panorama selvaggio, bellissimo, è
guastato in più punti da mucchi di rifiuti. A volte, piccole colline di bottiglie di vetro. Altre, piramidi di
oggetti ingombranti, dai frigoriferi ai divani.
Come se buttarli qui fosse più comodo che in discarica.
I 31 chilometri del primo giorno richiedono circa 8 ore di cammino, incluse foto, ambientamento,
chiacchiere con chi incontriamo. Rimpiangiamo di non essere partiti prima, perché non abbiamo il
tempo di scendere a fare un bagno alla Riserva naturale di Punta Bianca, uno spettacolo della
natura che dobbiamo limitarci a guardare dall’alto. Ma anche solo guardarla dà un senso di
meraviglia e riconoscenza.
A Palma siamo davvero stanchi, come succede in ogni primo giorno di qualsiasi cammino. Non
abbiamo le forze per andare a vedere almeno il Palazzo Ducale o la Chiesa Madre e nemmeno
per andare a cena: facciamo arrivare una pizza al b&b.

Giorno 2, da Palma di Montechiaro a Licata
Il secondo giorno è particolare, un mix di paesaggi che cambiano continuamente. Lasciata la
provinciale, attraversiamo una bella campagna, molto curata, dove i rifiuti spariscono. I segnali
sono pochi, il logo della Via (un viandante azzurro) lascia, sempre più spesso, il posto alle
tradizionali strisce biancorosse del Cai. Spesso ricorriamo alla traccia scaricata dal sito.
Numerosi saliscendi, passo passo, ci portano al mare. In lontananza si vede ancora Agrigento. A
mezzogiorno troviamo un posto per bere qualcosa sulla spiaggia, ci godiamo l’ombra guardando le
onde lunghe e piuttosto violente. Oltre a noi, ci sono solo altri due avventori, non italiani. È
immediato chiacchierare con il padrone di questo angolino, incuriosito dagli zaini e dagli scarponi.
Non conosce la Via Fabaria, gli facciamo vedere la cartina sulla Guida. Ci regala una bottiglia
d’acqua, un litro in più fa comodo e proseguiamo. Il sentiero piega spesso verso l’interno ma resta
quasi sempre in vista dell’acqua. Le prospettive sul mare si aprono su paesaggi costieri a onde,
l’acqua è verde, non c’è nessuno. Alcuni scorci tolgono il fiato.
Arriviamo a Licata dopo 26 chilometri, quasi tutti di sterrato, e un dislivello di oltre 500 metri in
salita e quasi 700 in discesa. Alloggiamo in un b&b segnalato dal sito, in un palazzo storico con
mattonelle originali che i proprietari stanno, camera dopo camera, ristrutturando e aprendo ai
viaggiatori. Lui descrive con entusiasmo la storia del luogo, lei è una camminatrice appassionata e
conosce la Fabaria. La cittadina, amata da Federico II, ci piace molto. I vicoli sono pieni di
coloratissimi murales, che mixano antico e moderno con un bell’effetto. C’è molta vita a tutte le
ore, bar pieni di gente fino a tardi, e non sono solo turisti.


Giorno 3, da Licata a Falconara
Il bello delle tappe corte è che consentono tante opportunità, ed oggi abbiamo solo 12 chilometri.
Così visitiamo il Museo del Mare, dove ancore preistoriche e vestigia dello sbarco degli Alleati
sono esposte con uguale cura. L’addetto probabilmente non vede mai nessuno, ed è felice di
farci da guida alle maggiori curiosità. Prendiamo il caffè nella piazza principale, il proprietario ci
racconta che ogni giorno arriva un quarto d’ora prima e toglie i rifiuti dalla piazza prima di aprire,
nonostante i concittadini gli diano contro perché “dovrebbe occuparsene lo Stato”. Anche lui non
cade dalle nuvole, quando si parla di Cammini; quando può accompagna il figlio a fare escursioni,
sa cosa vuol dire scoprire il mondo a piedi ed è contento che un pezzo di questo mondo sia il suo.
Partiamo a mattina inoltrata, è nuvoloso ma non piove.
Ville private sono edificate proprio sulla riva e nelle giornate tempestose può accadere che le onde arrivino ad infrangersi sulle mura di cinta, impedendo il passaggio. In questo caso non c’è alternativa, bisogna prendere l’autobus. Sulla spiaggia, mucchi sparsi di rifiuti. Molti cani nelle ville chiuse non fanno stare, talvolta, troppo tranquilli. Il percorso è bello, l’aria profuma di sale ma inizia a piovere, sempre più forte, e la sabbia si trasforma in una specie di plastilina che si incolla sotto le suole. Arriviamo in quattro ore, di cui due sotto l’acqua ma grazie al guscio collezione Titanium della Columbia sono perfettamente
asciutta. A Falconara c’è un pugno di case e un castello del XIV secolo, affacciato sul mare, ora dimora storica. Dormiamo in un b&b gestito da una signora di Gela che cucina benissimo, osserva che da quando c’è la Via Fabaria si lavora di più e sostiene che in agosto gli ospiti arrivano per il
mare ma “chi viene adesso sono viaggiatori”. Ogni camera ha un bel balcone, che solitamente
serve per rilassarsi al sole e oggi serve per stendere i vestiti bagnati e guardare i lampi, chiedendoci se domani toccherà prendere l’autobus.

Giorno 4, da Falconara a Gela
Per la quarta tappa, in effetti, ci tocca prendere l’autobus. Passa, quasi puntuale, alle 9,57, in 25
minuti copriamo il percorso che avremmo fatto in 5 ore a piedi (21 chilometri). Guardare dal
finestrino ci conferma che non avevamo alternative: pozzanghere gigantesche sull’asfalto e,
soprattutto, terra argillosa che imprigiona i piedi. Alle 10,30 siamo a Gela. Avremmo tempo per
vedere molto di ciò che offre. Ma.
È sabato ma i musei a Gela sono chiusi.
Chiuso il Museo archeologico.
Chiuso il Museo del Mare.
Chiusa la Cattedrale.
Irraggiungibile la Colonna dorica perché è nel parco del Mulino, che è chiuso.
Vediamo il sito archeologico solo da lontano e quello che vediamo ha dell’assurdo. A poca
distanza dalle vestigia greco-romane si staglia il colosso industriale del Petrolchimico con tanto di
ciminiera bianca e rossa. Una cicatrice permanente costruita nel 1965 in cambio del posto sicuro.
Che è durato poco, mentre questo sfregio rimarrà per sempre.
In compenso non piove più, e si può girare per vie acciottolate, bellissime. Cerchiamo invano
qualche piccolo ricordo con il logo della Via. Facciamo la spesa al supermercato, ci chiedono da
dove veniamo. Puntualmente, la seconda domanda, la terza al massimo, è sulle nostre impressioni
della Sicilia. Si accalorano a spiegare quello che c’è da vedere, amano la loro terra e
vorrebbero che la amassi anche tu.
Scoviamo una curiosità locale: un ristorante rigorosamente senza menu, sai cosa mangi ma non
sai quanto spendi. Noi 12 euro per un piatto di orecchiette con broccoli, speck, pomodori secchi e
pangrattato. In tutto il menù, dettagliatamente recitato a voce, non c’è traccia di pesce.

Giorno 5, da Gela a Niscemi
La quinta tappa ci porta a Niscemi; c’è il sole e portiamo più acqua. Camminando verso il
Petrolchimico ci accompagnano chilometri di rifiuti a bordo strada, che diradano quando
finalmente ci inoltriamo all’interno, in un paesaggio che passo passo diventa più verde. La giornata
è tersa, con nuvole che danno più profondità all’orizzonte. I segnali sono pochi, usiamo
prevalentemente le tracce scaricate. Riusciamo a mangiare un panino all’ombra di un albero.
Improvvisamente passano parecchie macchine e furgoncini, carichi di giovani, ci salutiamo.
Uno quasi si ferma, solo per gridarci “buon Cammino”. Poi camminiamo attraversando campi infiniti
di carciofi, da vedere sono bellissimi, peccato che la stagione del raccolto sia ancora lontana. Una
tipica trazzera, lastricata di mattoni e pietre di vario tipo, ci aiuta a percorrere l’ultimo tratto.
La piazza principale ci accoglie con due chiese che si fronteggiano e tanti avventori ai bar già in
azione per l’aperitivo. Sono circa le quattro e mezza. Laviamo sudore e scarpe, scendiamo e
veniamo gentilmente rapiti dal proprietario del b&b, che ci conduce al Belvedere raccontandoci
diversi aspetti del suo paese. Tramonto splendido sulla piana, si vede tutto il percorso che
abbiamo fatto, la ciminiera del petrolchimico, il mare.
Alle otto usciamo per andare a cena e troviamo la piazza gremita di gente che passeggia o beve
qualcosa, raggruppata per fasce di età. Ogni sera stanno fuori, è bellissimo. Noi alle dieci siamo a
letto, abbiamo 19 chilometri da smaltire, con 370 metri di salita tutti concentrati nell’ultima ora.




Giorno 6, da Niscemi a Caltagirone
Partiamo presto. Abbiamo ormai la tradizione, quando dal diradarsi delle case capiamo che sta per
finire la possibilità di trovare un bar, di fermarci per un secondo caffè. E nulla come il secondo caffè
è fonte di contatto con i locali. Anche quelli che incontriamo oggi non hanno mai sentito parlare
della Fabaria ma conoscono il territorio metro per metro, e ci consigliano di tutto, peccato che fare
e vedere tutto non sia possibile. Mi resta nel cuore la ragazza del bar, che non ha mai fatto un
Cammino e vorrebbe fare quello di Santiago.
Durante la notte è piovuto in abbondanza e i nostri passi sono molto rallentati dal terreno. I tentativi
di evitare l’effetto sabbie mobili non sempre riescono, ringrazio più volte le Konos trs Outdry MIDIn
della Columbia che ho ai piedi perché tengono benissimo su questa superficie, così come sulla
roccia, e sono confortevoli nei tratti asfaltati. In un Cammino come questo, dove ti trovi a
percorrere tanti chilometri, su superfici mutevoli e molto diverse, una scarpa come questa che è
leggera ma asciutta e molto efficace consente di affrontare agevolmente tutte le situazioni, e senza
nemmeno una vescica.
La tappa è molto ben segnata, dalla campagna è bello, guardando verso l’alto, vedere Caltagirone
che man mano si avvicina. Il fango è talmente scomodo che alcuni tratti di asfalto sono graditi. Un
paio di macchine si fermano, chi è a bordo vuole sapere dove stiamo andando, se ci serve
qualcosa. 23 chilometri, quasi 600 metri di salita, tanto impantanamento. Quando arriviamo ci
restano poche forze e le usiamo per vedere la Cattedrale e la celebre scala maiolicata,
parzialmente in manutenzione.
Giorno 7, da Caltagirone a Giammichele
Affrontiamo la settima tappa facendo il pieno di energie con il cornetto alla ricotta, che ormai è la
nostra colazione fissa. Un primo tratto è, purtroppo, sulla Statale, ma per fortuna qui le strade sono
poco frequentate. Non incontriamo mucchi di rifiuti stile discarica, ma le bottiglie sparse non
mancano mai. Intorno a noi, uscendo dalla città, campi coltivati e villette ben rifinite. Tanti mandorli
si protendono sulla strada, carichi di frutti ma trascurati. Facciamo scorta, più tardi spaccheremo i
gusci con qualche pietra. Spesso mangiamo mandorle durante i trekking ma queste sono buone il
doppio.
A lungo camminiamo a fianco della ferrovia. Quando la traccia piega nei campi i segnali
spariscono. Una prima volta chiediamo a un contadino, camicia rossa, barba brizzolata, occhi
profondi, che deve conoscere ogni centimetro di questa terra. Una seconda volta, a 4-5 km dalla
fine, prendiamo un sentiero seguendo la tracciatura on line ma un altro contadino che guida un
mostro meccanico ci manda indietro. Alla fine, ci arrendiamo, rinunciamo al sentiero e arriviamo a
Giammichele percorrendo la provinciale.
Arriviamo alle 16,30, dopo 20 chilometri e 400 metri di dislivello, e incontriamo Loredana. È la
referente di tappa e ci consegna il Munus, una pergamena riservata ai camminatori che, arrivando
qui, hanno percorso metà della Via Fabaria. Senza di lei non avremmo scoperto che questa città
è stata ricostruita come città aperta e antisismica da un principe studioso e illuminato, che
dopo il sisma del 1693 progetto e realizzò un centro urbano a pianta esagonale, con perfette vie di
fuga che, contemporaneamente, sono anche vie di entrata. Una città aperta a chi arriva, in cui ci si
può sempre ritrovare. E dove, dopo 153 chilometri in 7 giorni, si conclude il nostro viaggio.
Da Giammichele, infatti, si può proseguire verso l’Etna, fino a Randazzo, o piegare verso Ragusa
e arrivare fino a Noto, seguendo la variante Iblea. Altri progetti di viaggio iniziano a formarsi in
testa. Ci vorrà un altro autunno.
Il nostro ultimo incontro è in frutteria, con Giovanna, che ci racconta di quanto sia aumentata la
frutta per la mancanza di acqua che riduce i raccolti. Quando le spieghiamo che vogliamo solo due
pesche perché dobbiamo fare i conti con lo spazio e il peso nello zaino ce le regala.
È il nostro ultimo ricordo di questa terra generosissima e di una Via che può andare molto avanti.



PER CHI VUOLE METTERSI IN CAMMINO
Sulla Via Fabaria non ci sono molte fonti di informazione, e anche questo ne fa una meta
intrigante.
Quelle che ci sono, sono di provata utilità e affidabilità:
Davide Comunale, Irene Marraffa, Salvatore Balsamo, La Via Fabaria. 300 chilometri in cammino
da Agrigento all’Etna, 2023, Terre di mezzo Editore www.viefrancigenedisicilia.it – fornisce, tra l’altro, tutte le informazioni su come ottenere le credenziali. Il consiglio è di procurarsele prima di partire.
Su Facebook è attiva la Community Vie Francigene di Sicilia, dove vengono scambiate
informazioni e aggiornamenti.
[email protected] mail alla quale chiedere tutte le informazioni e aggiornamenti
intreccimedia.it post in 7 puntate sulla Via Fabaria
Vivo a Roma e in Trentino. Giornalista professionista, appassionata di outdoor, scrivo prevalentemente sulle tematiche legate alla montagna, al trekking e ai cammini. Mi piace condividere le meraviglie che incontro, e per questo collaboro all’organizzazione di trekking in posti poco conosciuti, dal Molise all’Australia.
• [email protected]